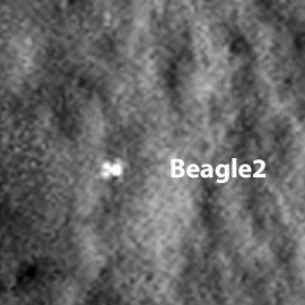.jpg) |
| Figura 1. Beagle-2 come visibile dall'HiRiSe camera (credit NASA) |
Il ritrovamento è opera di un ex collaboratore del progetto, Michael Croon, che dopo scrupolose analisi delle foto raccolte dalla fotocamera ad alta risoluzione HiRiSe, montata a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA, aveva notato in una di queste qualcosa che poteva rappresentare proprio la sonda perduta, sebbene, con un diametro di circa 2 metri, al limite della risoluzione dello strumento. Successive ricerche hanno confermato che si trattava proprio di Beagle-2 (figura 1) e hanno consentito di rintracciare anche altri componenti rilasciati durante l'atterraggio (figura 2).
Ma partiamo dall'inizio. L'ente spaziale britannico lanciò nel 2003 da Baikonur un lander, una sonda priva di ruote, che doveva atterrare su Marte per compiere alcune osservazioni. A bordo della missione Mars Express, la sonda era assai sofisticata per l'epoca e si chiamava come la nave su cui Charles Darwin fece il suo giro nel mondo intorno al 1830. Fu proprio quel viaggio a bordo del Beagle a rivoluzionare le nostre conoscenze della vita sulla Terra e a fornire le prove dell'evoluzione. Analogamente, Beagle-2 venne invece pensata per verificare l'eventuale presenza di forme di vita passate e presenti su Marte.
La sonda disponeva di fotocamere stereo, di un microscopio, ed anche di un “trapano”, montato al termine di un lungo braccio meccanico pieghevole, in grado di estrarre campioni dal sottosuolo per eseguire successive analisi in situ.
Il 19 dicembre 2003 la sonda si separò come previsto dalla navicella madre in orbita marziana, Mars Express. Per risparmiare, non era stato previsto l'invio di alcun dato di telemetria alla navicella madre. Sei giorni dopo, esattamente il giorno di Natale del 2003, l'ESA attese quindi un segnale di conferma del suo arrivo sulla superficie di Marte. Purtroppo non accadde nulla.
Diversi radiotelescopi e centri di ascolto, inclusa l'enorme antenna di Jodrell Bank, vennero allora puntati verso Marte, nel tentativo di raccogliere un minimo segnale di “vita” da Beagle-2. Ancora nulla. Dopo qualche mese le ricerche vennero abbandonate, causando grande frustrazione nei circoli scientifici, soprattutto nel Regno Unito, dove la sonda era stata concepita da un consorzio universitario. Questo disastro causò certamente un ripensamento nella politica spaziale britannica, e il suo successore, Beagle-3, non vide mai la luce.
Le ipotesi sulla fine di Beagle-2, in mancanza di alcun dato sensibile, furono diverse. Il rapporto presentato dalla Commissione di inchiesta all'Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel 2004 per chiudere la questione proponeva diversi scenari possibili del fallimento. Un paracadute che non si era aperto, un problema allo schermo ablativo richiesto durante la discesa nella sottile atmosfera marziana, la mancata apertura degli “airbag” prima del contatto col suolo. In molti cercarono senza successo di identificare i resti del lander o il paracadute nelle foto di Marte disponibili allora. Ciò rende ancora più incredibile il fatto che in realtà, come si sa solo adesso, Beagle-2 era atterrato con successo a soli 5 km dal centro dell'enorme ellisse prevista per l'atterraggio, che aveva una dimensione di 500 per 100 km. Un errore dell'1% quindi, che conferma la straordinaria qualità della missione e in particolare delle complesse manovre di EDL (“Entry, Descent and Landing”, o “Ingresso, discesa e atterraggio” in italiano).
Ma quali furono le cause di quel silenzio radio, visto che, come sappiamo adesso, la sonda sembra essere atterrata intatta? Guardando le foto ad alta risoluzione del lander non si vede molto, ma si capisce che almeno uno dei cinque pannelli solari che dovevano aprirsi dopo l'atterraggio come petali di un fiore non lo fece, coprendo così le antenne ed impedendo qualsiasi comunicazione con l'esterno. Può essere che durante l'atterraggio il lander, protetto dagli enormi airbag che dovevano attutire l'urto facendolo rimbalzare più volte (una tecnica standard adottata anche per i rover Opportunity e Spirit della NASA, sebbene non per Curiosity), si è deformato leggermente ed uno dei mille automatismi necessari all'apertura dei pannelli solari si è bloccato. Nessuno potrà dirlo con certezza fino al giorno in cui non si potrà fare della “archeoastronautica” su Marte, magari come passatempo di futuribili turisti e coloni.
 |
| Figura 3. Beagle-2 a circa 20 m da Mars Express, dopo la separazione in orbita. Questa era l'ultima sua foto circolante, fino a ieri. |
Comunque sia, la realtà è che ce l'avevano quasi fatta, oggi ne abbiamo la prova. Complimenti sentiti a tutti, quindi. Soprattutto a quel Prof. Colin Pillinger, della Open University di Milton Keynes, UK, leader ed ideatore dell'intero progetto, spentosi circa un anno fa e che quindi non ha mai avuto una risposta alle mille domande che si sarà posto riguardo alla fine misteriosa del suo “bracchetto”.
Paolo G. Calisse, 16 gennaio 2015
Scritto da Paolo Attivissimo per il blog Il Disinformatico. Ripubblicabile liberamente se viene inclusa questa dicitura (dettagli). Sono ben accette le donazioni Paypal.







